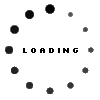LA DIPENDENZA AFFETTIVA: LE FASI DI UNA PATOLOGIA
Da quando è stata isolata e descritta nella sua autonomia strutturale, la sindrome delle «donne che amano troppo», della dipendenza affettiva, o love addiction – come viene definita nei paesi anglosassoni –, è balzata agli onori della cronaca. Da allora gli interventi sui media si sono moltiplicati a ritmo vertiginoso. Vorrei riportare in questa pagina il testo di una delle prime interviste che ho dato sull’argomento, per l’immediatezza e la spontaneità con le quali i concetti si sono organicamente disposti nel corso del piacevole dialogo.
Domanda: Gentile dott. Ghezzani, confrontandomi con alcune donne (mi pare siano loro ad essere le più colpite dalla patologia della «dipendenza affettiva»), mi è capitato di riscontrare da parte di molte di esse un’identificazione con i comportamenti descritti da lei nei suoi libri Volersi male e Quando l’amore e una schiavitù, entrambi editi da Franco Angeli, e di cui ho ritrovato traccia anche nel famoso libro Donne che amano troppo di Robin Norwood. Lei parla di psicopatologia, e anche la Norwood presenta casi molto estremi di disturbi, con alle spalle precedenti di famiglie lacerate o in generale gravi traumi. Ma l’ampia diffusione del problema non sta forse a indicare che, al di là dei casi più estremi e propriamente patologici, esista una generale tendenza di molte donne ad affrontare in questo modo deviante il rapporto amoroso? Non si può parlare, a fianco della vera e propria patologia, di una fenomenologia di minore gravità, ma molto estesa, legata a fattori sociali? Un senso di insicurezza generale che spinge molte donne ad adottare almeno in parte i comportamenti ossessivi tipici della love addiction.
Risposta: In effetti, la sindrome della dipendenza affettiva sembra avere ormai una diffusione da pandemia, sembra cioè una «malattia» in via di diffusione ovunque esistano rapporti fra uomini e donne. Da ciò possiamo dedurre che, per quanto la storia la documenti anche in altre epoche, la sua diffusione odierna testimonia di un malessere specifico dell’epoca attuale. La mia disciplina, la Psicoterapia dialettica, è una psicoanalisi di tipo socio-storico, e va appunto alla ricerca dei fattori ambientali (storici e sociali) che stanno alla base di tutte le psicopatologie, maggiori o minori.
Nel caso delle «donne che amano troppo» io vedo innanzitutto quei fattori storici e sociali che insegnano e impongono da millenni alle donne la devozione amorosa come la virtù massima che una donna debba possedere per sentirsi realmente donna. La devozione amorosa non riguarda solo il marito (o il «partner», nella versione moderna), ma anche un proprio genitore, i propri figli, spesso intere reti di parentela. Per la donna queste sono persone da amare in modo assoluto, in virtù di un vero e proprio annullamento di sé che rappresenta, in un certo senso, un vero e proprio «test di femminilità». Senza questa «abilità» a devolversi nel bene altrui e a farsi riconoscere «amabile», una donna semplicemente non si sente donna. Per cui, se un uomo la rifiuta, la donna rifiutata non solo si sente brutta o odiosa, ma non si sente più donna: la sua identità di genere è distrutta.
D: Quali sono i principali sintomi che una persona può cercare di riscontrare da sé?
R: Ansia più o meno marcata ad ogni distacco, sentimenti di vuoto e di smarrimento quando si è soli, gelosie immotivate e ossessive, controllo telefonico o anche fisico del partner, a gradi estremi odio mortale cui segue il bisogno di essere puniti, talvolta un dolore lacerante, lancinante al petto, apparentemente senza motivo, che rappresenta la sensazione di poter morire a causa dell’assenza della persona amata.
D: Ha avuto esperienze di questo genere tra le sue pazienti o ha conoscenza diretta di casi simili? Ce ne può raccontare uno che ritiene più emblematico?
R: Ci sono persone che sembrano del tutto perse nel loro malessere, incapaci di capirlo in alcuno dei suoi aspetti, ma che invece mancano solo di pochi nessi logici, di poche rigorose deduzioni, per comprenderlo a fondo e risolverlo. Cristina è una di queste. La conobbi attraverso Internet, dopo aver pubblicato sul mio sito Psicoterapia dialettica, (indirizzo www.psyche.altervista.org), un articolo sulla dipendenza affettiva. Dalle sue parole vorrei estrapolare i concetti più interessanti, punteggiandoli con delle interpretazioni.
Dice Cristina:
«E’ da quando ho diciassette anni che sono consapevole di essere una donna che ama troppo (ora ho venticinque anni). Ho avuto un’infanzia molto tormentata con genitori che chiunque ha sempre definito pazzi, infatti uno dei due si è tolto la vita qualche anno fa. A diciotto anni ho conosciuto un uomo che ha fatto cambiare in negativo il corso della mia vita… In quei durissimi tre anni ho affrontato per la prima volta la mia «malattia»… Non riuscivo a darmi una spiegazione dell’ansia, degli struggimenti, del mio farmi calpestare in tutti i modi…»
Cristina pone alla base del suo malessere la crisi di coppia dei genitori e il suicidio di uno dei due: intuisce che la loro autodistruzione esistenziale ha prodotto in lei un’analoga tendenza masochistica. Di conseguenza, si rende anche conto che, alla base della sua dipendenza affettiva c’è una vocazione non solo ad amare, ma soprattutto a «farsi calpestare in tutti i modi», intuisce, dunque, la relazione esistente fra masochismo e ricerca dell’umiliazione amorosa.
Prosegue:
«In conseguenza di questa prima storia, ho avuto un esaurimento nervoso, ho dovuto abbandonare il lavoro per curarmi…, ma alla fine sono riuscita a lasciare quell’uomo, e sono diventata dai vent’anni in poi di un cinismo incredibile, dovevo apparire sempre a me stessa e agli altri forte, magnetica, indistruttibile. Il mio amor proprio aveva preso in passato troppi duri colpi. Ora, volevo essere io a fare la parte della stronza con i ragazzi, purtroppo anche con chi amavo e quindi con le storie importanti che sono seguite».
Cristina è consapevole anche di questo secondo passaggio. Dopo la ricerca dell’umiliazione masochistica, il soggetto malato di dipendenza affettiva vuole «vendicarsi».
Ecco cosa dice:
«Sono consapevole di aver trattato il mio nuovo ragazzo veramente male. Mi ha dimostrato una dolcezza, una comprensione e una devozione incredibili anche quando soffriva a causa mia. E’ una via di mezzo tra il ragazzo che a noi «donne che ci vogliamo male» può piacere – per le sue negatività – e un bravo ragazzo. A noi la negatività maschile ci eccita particolarmente…»
Questo è un passaggio importante per capire lo strutturarsi della patologia da dipendenza. Chi è affetto da dipendenza affettiva patologica ha: 1) una tendenza masochistica di base, dovuta a una bassa autostima. 2) L’asservimento affettivo è il primo tentativo che egli fa per ottenere dal partner segni di gratitudine e stima e riscattare questa penosa autopercezione. Tuttavia, se pure questi segni arrivano, il soggetto dipendente finisce per sentirsi umiliato della sua condizione servile, pensa di essere ingannato e sfruttato, sicché avvia una nuova fase. 3) Tenta a questo punto di riscattare la percezione negativa di sé mediante una «ribellione»: il soggetto diviene insensibile, aggressivo, sfidante, fino a livelli di esaltazione maniacale, per ribaltare il rapporto di potere. 4) Ma così facendo aggrava il senso di colpa originario e l’autostima peggiora. Infine, 5) il soggetto ha bisogno di farsi punire a causa della sua ripetuta negatività, e lo fa attraverso vecchi o nuovi partner.
Dice ancora Cristina:
«Ovviamente mi sono sempre scelta persone che non facevano per me, persone nevrotiche o psicopatiche: i classici stronzi. All’inizio era splendido ripagare persone che sapevo mi avrebbero già dall’inizio fatta soffrire usando le loro stesse tattiche e strategie. Mi sentivo forte, potente. Ai miei compagni ne ho fatte passare di tutti i colori, mi piaceva vederli soffrire. Sono consapevole di essermi comportata da pazza, ma volevo farmi vedere pericolosa per tutelarmi, per dimostrare che nessuno poteva più umiliarmi e farmi del male. Ho recitato questa parte per anni… Infine ho capito che ero io a trovare loro dei pretesti per farmi trattare male, e che usavo poi quegli stessi pretesti contro di me, per potermi dire che se loro mi facevano del male era tutta colpa mia…».
Questa complessa dinamica può infine facilmente cronicizzare nella depressione.
Sono dunque queste in sintesi le fasi di instaurazione della dipendenza affettiva:
1) Soggezione morale e fisica (tendenza masochista di base): il soggetto (uomo o donna che sia) si sente di scarso valore o di valore negativo, quindi ha bisogno di «servire» qualcuno per ottenere da lui un giudizio positivo. All’idea di averlo ottenuto, sperimenta un esaltante sentimento di sollievo e di gratitudine.
2) Ciclicità depressivo-maniacale: il soggetto prende coscienza della propria immagine interna negativa (di persona debole o cattiva o pervertita), si addolora di ciò e se dapprima si sacrifica per il bene del partner poi, sentendosi umiliato, odia il proprio servilismo e/o il dominio da parte del partner, quindi si vuole vendicare.
3) Vendetta: egli/ella si vendica divenendo freddo e sfidante nei confronti del partner.
4) Senso di colpa: di conseguenza, prova sensi di colpa e bisogno di essere punito.
5) Ciclicità sadomasochista (bisogno di punizione e rilancio della sfida): alla fine, il soggetto scivola in una nuova e più grave depressione. La depressione può implicare giudizi negativi su di sè o sul mondo, quindi di bisogno di mortificarsi o di farsi punire o può sfociare in un drammatico senso di vuoto. Oppure può virare – per ribellione – verso una nuova sfida.
Dice Cristina:
«A parte certe tragedie famigliari, non mi manca veramente niente… ho buoni amici, quest’anno ho ottenuto il lavoro che sognavo, leggo, scrivo, coltivo anche un interesse artistico in una compagnia teatrale. Ma anche se mi sento appagata, avverto puntuale una sorta di vuoto, di depressione latente, un senso di noia e di inutilità. Sicché mi rimetto alla ricerca di una relazione totalizzante per colmare quel terribile sentimento. La mia è stata una continua fuga più che da me stessa, da questa atroce sensazione di non essere viva, da questa impalpabile percezione che va oltre qualsiasi razionalità. Ciò che faccio ogni giorno lo faccio per dimenticare questa sensazione. Da qui anche le relazioni: quando ci si attacca a «quel tipo» di persone non è per vero amore. Io, quando trovo un uomo di «quel genere», ho una sensazione di innamoramento non perché lo amo davvero, ma perché amo quel senso di totalità che mi dà l’illusione di sentirmi viva, annullando la sensazione del vuoto. Arrivando al bandolo della matassa, della mia matassa, il punto da cui iniziano certi orrori nasce proprio da questo grande vuoto iniziale, o esistenziale».
Per capire appieno il significato di questo angoscioso senso di vuoto occorre prendere la parola «vuoto» non come una metafora ma alla lettera. In effetti, la donna che ha annullato se stessa in funzione delle esigenze maschili, e che ha fatto il deserto intorno a sé (deserto di persone, di interessi, di vocazioni personali e di futuro…) ha realmente fatto il vuoto intorno e dentro di sé. Ogni cosa che non sia il suo uomo è allontanata dall’angoscia di perderlo e dal senso di colpa di «tradirlo»: il vuoto che infine la donna sperimenta è dunque la sua oggettiva realtà, è l’angoscia morale per ciò che ha fatto a se stessa.
Dal mio punto di vista, dunque, questo sentimento di nullità è l’inizio e la fine del percorso. Si comincia con la bassa stima di sé (legata all’educazione tradizionale, cioè dal vuoto imposto dalla cultura familiare e sociale), e si finisce con una stima ancora più bassa, dovuta alla percezione di una negatività personale irrimediabile.
D: Dottor Ghezzani, per finire, qual è in questi casi, in genere, il ruolo giocato dai partner?
R: Spesso il partner tipico che si lega a persone affette da love addiction ha una patologia affine. Di solito è una persona fortemente insicura e allo stesso tempo narcisista, che ottiene un lenimento delle sue angosce e una certa soddisfazione dell’autostima proprio grazie all’adorazione e al masochismo del suo partner dipendente affettivo. Ormai si parla infatti di co-dipendenza. Questo termine tecnico vuol dire che entrambi i contraenti di questo tipo di rapporto sono dipendenti l’uno dall’altro, ma in modi diversi. Nei miei libri, io chiamo questa forma complessa di rapporto a due patologie «collusione sado-masochista».
di NICOLA GHEZZANI
Psicoterapeuta – Roma
Psicologo, Psicoterapeuta
Studio in Milano, Roma, Napoli e Vietri sul Mare (Sa)
per contatti e consulenze private tel.320-8573502 email:cavalierer@iltuopsicologo.it